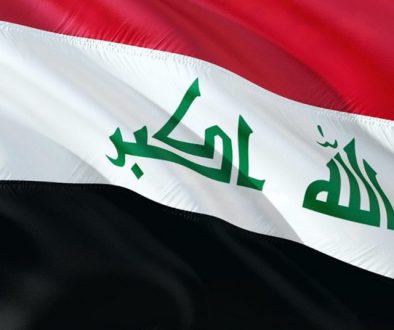Le donne nel mondo islamico: quando la fede diventa violenza
di Marita Langella
Tempo di lettura 5'
Lo continuano a gridare con un coraggio che spesso supera la consapevolezza del momento storico che si trovano a vivere. Le donne afgane dal 19 agosto scorso, giorno dell'indipendenza dell'Afghanistan, sono scese in piazza a Kabul per rivendicare una condizione di emancipazione e libertà che i Talebani vogliono negare. Sette giovani in tutto, tra queste Crystal Bayat di 24 anni, ha deciso di rivelare al mondo il proprio nome nonostante il pericolo che corre, ed è subito diventata "la donna con la bandiera afghana". L'accusa che muovono ai talebani è di atti di crudeltà e violenza fisica e psicologica, di colpi da fuoco sparati sui civili inermi, di caccia all'uomo porta a porta e di uccisioni e massacri, mentre risolute spiegano all'Occidente attraverso messaggi su whatsapp il significato di sfilare issando la bandiera. La maggior parte di loro sogna un'istruzione completa, un lavoro pieno, un matrimonio con un uomo che amano e tutti quei diritti inalienabili che accomunano gli esseri umani senza discriminazioni e false ideologie condotte in nome di Dio, e la bandiera che sventolano è proprio il riconoscimento di un orgoglio nazionale che impone il rispetto della Costituzione in cui credono.
"Mia madre mi ha raccontato molte storie dolorose sul periodo in cui i talebani governavano il Paese, quando io ero piccolissima", racconta Crystal ai media stranieri, perché lei del regime talebano prima del 2001 ne ha sentito solo parlare dalla famiglia e sa che molte donne afghane sono state aiutate da sua madre che è un medico di lunga esperienza. Le nuove generazioni che oggi scendono in piazza contro il regime dei fondamentalisti sono cresciute nella società dei cambiamenti imposti dall'Occidente nel Paese dopo l'11 settembre e come Crystal racconta, hanno potuto studiare, frequentare l'università e conseguire master e dottorati. Ora che il Paese è ripiombato nel caos e rischia di tornare indietro di 20 anni, sono proprio quelle ragazze/i a dare voce a un popolo terrorizzato attraverso attività politiche, sociali, civili e culturali.
Ed è con questi propositi che il 19 agosto scorso un gruppo di loro, si sono recati sulla collina di Wazir Akbar Khan in occasione della giornata dell'indipendenza, li dove si trova la bandiera più grande dell'Afghanistan, per issarne accanto un'altra, ma ancora una volta sono stati minacciati e alcuni di loro picchiati dai soldati talebani. Perché il regime starebbe conducendo una strategia che si muove su un doppio binario, farsi ufficialmente accettare dalla comunità internazionale attraverso una dialettica moderata e aperta alle richieste del popolo sulla strada del cambiamento, mentre perseguono in realtà un modello di società fondato sull'anti occidentalismo, sul patriarcato e sulla costruzione di una società chiusa votata agli insegnamenti della religione islamica. E' proprio alla sharia ovvero alla legge islamica, parola che in arabo significa retta via, che i talebani si appellano e cioè a quell'insieme di tradizioni e pareri non codificati nel Corano che risentono di continui cambiamenti e che si basano su cosa è proibito e cosa no, oltre che sulla sunna, la tradizione creata dai versetti del Profeta. Una dimensione religiosa che si fonde però con quella politica, per il controllo del potere, e che vede gli uomini occupare una posizione di superiorità rispetto alle donne che vanno mantenute e poste sotto il controllo maschile, e che per questo finiscono vittime di strumentalizzazioni e propaganda violenta. Nella maggior parte dei casi oggetto di lapidazioni, stupri, mutilazioni e altre forme di atrocità, perché per certi uomini uccidere è un atto da nulla.
Una condizione quella delle donne nel mondo islamico che oltre all'Afghanistan interessa altre etnie, come ad esempio quelle di fede yazida in Iraq. Questa minoranza religiosa diffusa nelle regioni del Sinjar iracheno da prima della comparsa dell'Islam, è stata vittima di un vero e propro massacro da parte dell'ISIS nel 2014, mentre le donne yazide sono state rapite, violentate ripetutamente, schiavizzate e vendute in molti casi in Arabia Saudita, Egitto, Qatar, Tunisia e Turchia. Di loro non si conosceva quasi nulla finchè la storia di una di loro Nadia Murad, ha destato interesse a livello mondiale, tanto da ispirare un film della regista francese Caroline Fourest dal titolo Red Snake, uscito nel 2019. La Murad tenuta prigioniera dallo Stato Islamico, oggi è un’attivista e prima Ambasciatrice Onu per la dignità dei sopravvissuti alla tratta di esseri umani, insignita anche del Premio Nobel per la Pace nel 2018. Storie di invisibili che oggi hanno volti e voci che raccontano gli orrori delle azioni perpetrate dai terroristi, come sostiene la ginecologa yazida Nagham Nawzat Hasan, che ha curato oltre 1000 donne sfuggite all' ISIS. La sua esperienza di medico è confluita in più di 200 storie scritte durante le sue visite alle sopravvissute, che oggi possono contare su una ONG da lei fondata chiamata "Hope Makers for Women", che offre supporto medico e psicologico nei campi allestiti per ospitare la minoranza yazida. Si stima che oltre 6.000 donne e ragazze siano state vendute come schiave, 1400 di loro risultano disperse, mentre gli uomini e i ragazzi di età superiore a 12 anni sono stati separati dalle loro famiglie. Chi si opponeva veniva ucciso pubblicamente.
Una delle prime sopravvissute con la quale la dottoressa ha lavorato è proprio Nadia Murad che le ha inviato una copia del suo memoriale con una dedica scritta a mano che recita: "Alla cara dott.ssa Nagham. Ognuno di noi ha combattuto l'ISIS più che poteva, ma tu l'hai combattuto con l'arma più potente il giorno in cui hai deciso di guarirci. Quando hai riportato in vita le nostre anime".
Oggi nel mondo islamico lo status delle donne continua a seguire un'evoluzione lenta come lo è stato analogamente per altre religioni. Un cambiamento dovrà partire necessariamente da quelle donne che attraverso esperienze di vita condotte in Occidente e con una consapevolezza acquisita lontana dai modelli culturali di base, avranno l'opportunità di studiare, lavorare e affermarsi pienamente. Solo così una volta tornate nel loro Paese potranno dar vita a quel cambiamento endemico che parte dal basso, dalla società, per influenzare le leggi che incideranno sulla condizione delle musulmane.
Bibliografia
- Corriere della Sera (Viviana Mazza), (Marta Serafin)
- UNHCR ITALIA (The UN Refugee Agency)
Immagine: Donne musulmane durante una protesta ad Ankara
Autore: Burhan Ozbilici/Ap